LA NUOVA POLITICA COMMERCIALE DEGLI STATI UNITI - LA NOTA DEL CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA
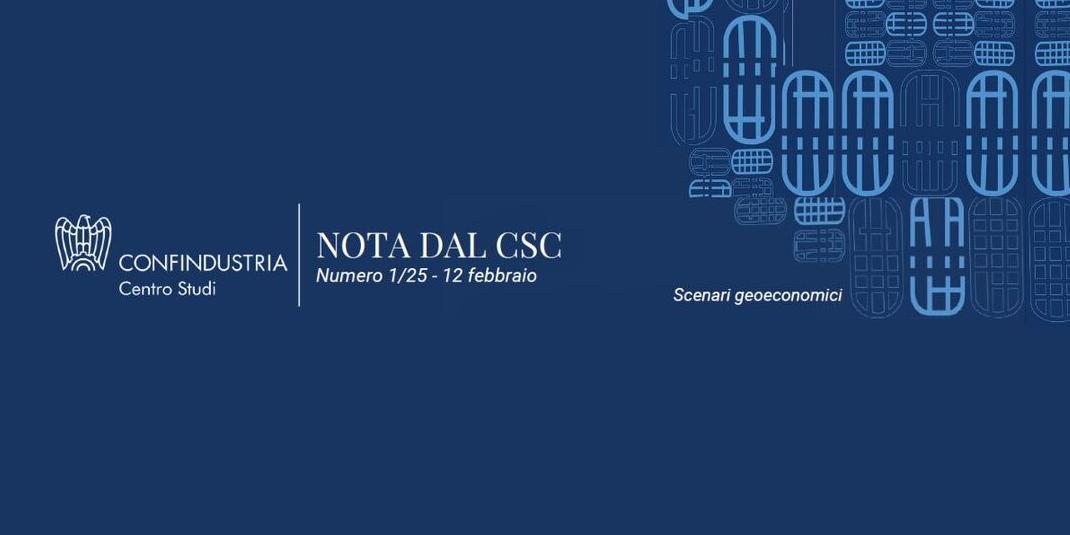
Il Centro Studi di Confindustria ha bubblicato la nota “La nuova politica commerciale degli Stati Uniti: scenari e canali di trasmissione. I settori e i prodotti europei e italiani più a rischio”.
- La America First Trade Policy della seconda amministrazione Trump si annuncia più aggressiva e imprevedibile dell’approccio adottato nel primo mandato e minaccia una escalation protezionistica che potrebbe ridisegnare la geografia degli scambi mondiali.
- Il 1° febbraio 2025 il neopresidente USA ha annunciato dazi addizionali del 25% sulle importazioni da Canada e Messico, introdotti il 3 febbraio e sospesi l’indomani per un mese, e del 10% su quelle dalla Cina, entrati in vigore con efficacia immediata, e la reintroduzione di tariffe al 25% su tutti gli acquisti all’estero di acciaio e alluminio, che erano sospese per un gruppo di paesi “amici”, tra cui quelli UE (dal 2021). I paesi colpiti hanno annunciato contromisure tariffarie sulle merci USA.
- Obiettivi e strumenti delle politiche USA travalicano l’ambito commerciale, per includere temi di sicurezza nazionale e geopolitica: riduzione delle dipendenze dall’estero, difesa dell’industria, rafforzamento della leadership nelle nuove tecnologie.
- Dazi selettivi per paese e/o prodotto sono uno strumento per: negoziare obiettivi diversi, come il controllo delle frontiere (escalate to de-escalate); ridurre la forza contrattuale delle controparti (divide et impera); contenere la traiettoria tecnologica della Cina (decoupling).
- I dazi sono una tassa, pagata dagli importatori, che si scarica su famiglie e imprese statunitensi. L’impatto finale è un aumento (una tantum) dei prezzi al consumo. L’entità della trasmissione dipende dalle politiche di prezzo degli esportatori (che possono abbassare i loro prezzi) e dei produttori domestici (i cui margini possono assorbire parte dell’aumento dei costi) e dagli aggiustamenti del cambio (che anticipano i dazi e possono compensarli). I lavori empirici basati sull’esperienza della prima amministrazione Trump mostrano che i dazi si sono scaricati interamente su prezzi di acquisto (con delle eccezioni, per esempio nell’acciaio), con un impatto finale di minori margini per le imprese e maggiori prezzi per i consumatori.
- I dazi non incidono significativamente sul deficit commerciale ed hanno impatto negativo sul PIL del paese che li impone: circa -0,2% stimato in seguito ai dazi del Trump I (2018-2019). L’impatto si amplia nel lungo periodo, perché la minore concorrenza internazionale e la sopravvivenza di imprese meno efficienti riducono la crescita economica potenziale.
- Sotto il profilo del consenso politico, i dazi sono percepiti in maniera positiva fra i settori e nei territori maggiormente esposti all’integrazione globale dei mercati, alla competizione internazionale ed alla concorrenza di produttori considerati rivali, soprattutto quelli accusati di adottare pratiche commerciali illecite e/o sleali, come la Cina.
- A livello internazionale gli effetti sono potenzialmente molto distorsivi, lungo molteplici canali di trasmissione: dalla riconfigurazione dei flussi bilaterali e delle catene di fornitura su scala globale; ai flussi intra-company, che nel caso degli USA riguardano molte imprese multinazionali; all’incremento di flussi e triangolazioni commerciali e produttive in paesi terzi collegati (ad es. Vietnam nel caso della Cina e Messico nel caso degli USA); alla digressione generalizzata degli scambi (le merci che non trovano più accesso al mercato USA cercano altre destinazioni); alla rilocalizzazione negli USA di alcune filiere strategiche (come ad esempio quella dei metalli); all’inaridimento complessivo delle collaborazioni industriali, incluse quelle votate alla ricerca e all’innovazione.
- Data l’eterogeneità e l’asincronia di questi effetti, l’impatto complessivo è, dunque, difficile da stimare. Esso dipende da molte variabili: la distribuzione dei dazi per paese/prodotto, l’aliquota e la durata dei dazi, l’elasticità della domanda al prezzo dei prodotti, la reazione del tasso di cambio, l’esposizione ai dazi dei partner commerciali. Per l’Italia e l’Europa si prefigurano considerevoli rischi, accanto, tuttavia, ad alcune opportunità, in termini di quote di mercato potenzialmente contendibili nel mercato USA liberate dal decoupling con la Cina.
- Non di meno, queste variabili alimentano l’incertezza, che frena gli scambi di merci, servizi e capitali produttivi. In base a precedenti analisi del Centro Studi Confindustria, un aumento persistente del 10% dell’incertezza mondiale sulla politica economica è associato a una minore crescita (nel trimestre successivo) di quasi mezzo punto percentuale del commercio mondiale, a seguito sia di un rallentamento dell’attività industriale che di una minore intensità degli scambi.
- Nel caso dell’Italia, le connessioni economiche sono estremamente profonde. Gli USA sono la prima destinazione extra-UE dell’export italiano di beni e di servizi e la prima in assoluto per gli investimenti diretti all’estero.
- Nel 2024 le vendite di beni italiani negli USA sono state pari a circa 65 miliardi di euro, generando un surplus vicino a 39 miliardi. Nonostante un calo nell’ultimo anno, il mercato statunitense ha offerto il contributo più elevato in assoluto alla crescita dell’export italiano dal pre-Covid.
- Gli investimenti diretti dell’Italia verso gli Stati Uniti ammontano a quasi 5 miliardi all’anno, il 27% del totale (media 2022-2023); 1,5 miliardi annui, invece, i flussi dagli USA in Italia. Il deflusso netto di capitali è un segnale di dinamicità delle multinazionali italiane (anche grazie agli incentivi USA), ma anche di limitata attrattività del mercato italiano per i capitali americani.
- Le multinazionali americane sul territorio italiano, comunque, sono le prime per numero di occupati (più di 350mila nel 2022), contribuendo per più di un quinto al valore aggiunto nazionale e alla spesa in ricerca e sviluppo. La presenza delle multinazionali USA è particolarmente importante nella manifattura italiana, dove sono concentrati più di 110mila addetti. Nel comparto elettronico e ICT, il 90% delle multinazionali extra-UE è di proprietà USA.
- Quasi tutti i settori manifatturieri italiani godono di un surplus commerciale con gli Stati Uniti. Macchinari e impianti (primo settore esportatore), farmaceutica (primo settore importatore, nonostante un surplus pari quasi al doppio del valore), autoveicoli e altri mezzi di trasporto, alimentari e altri beni manifatturieri generano, insieme, quasi tre quarti del surplus italiano con gli USA (dati 2023).
- Il settore primario, invece, registra un deficit, alimentato soprattutto dagli acquisti di gas naturale, che hanno contribuito a sostituire le forniture russe (per quasi 7 miliardi di euro in Italia e 70 in Europa nel 2023). Un aumento dell’import di gas potrebbe rientrare nel negoziato transatlantico stemperando le istanze di riequilibrio della bilancia commerciale.
- L’export italiano è più esposto della media UE al mercato USA: 22,2% delle vendite italiane extra-UE, rispetto al 19,7% di quelle UE. Tra i settori maggiormente esposti spiccano le bevande (39%), gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto (30,7% e 34,0%, rispettivamente) e la farmaceutica (30,7%).
- Viceversa, l’import italiano è meno dipendente della media UE dalle forniture USA: 9,9% rispetto a 13,8% degli acquisti extra-UE. I comparti più dipendenti sono il farmaceutico (38,6%) e le bevande (38,3%), che lo sono anche dal lato dell’export. Ciò evidenzia la profonda integrazione di queste filiere produttive ed il loro elevato rischio in caso di dazi e ritorsioni.
- L’esposizione italiana agli USA aumenta se si considerano anche le connessioni produttive indirette, cioè le vendite di semilavorati che sono incorporati in prodotti per il mercato USA. In base a stime del Centro Studi Confindustria, è attivata direttamente e indirettamente dal mercato USA una quota significativa delle vendite totali (estere e domestiche) del farmaceutico (17,4%) e degli altri mezzi di trasporto (16,5%). Seguono gli autoveicoli, i macchinari e impianti, gli altri manifatturieri, pelli e calzature. Per il totale manifatturiero, il peso degli USA come mercato di destinazione è pari a circa il 7% delle vendite (5% da flussi diretti e il restante da connessioni indirette).
- L’Italia e gli altri paesi UE esportano una grande varietà di prodotti negli USA (80% di tutte le categorie vendute dall’Italia nel mondo e più del 90% dalla UE).
- Per individuare i prodotti più a rischio di eventuali dazi USA, abbiamo formulato tre criteri granulari di selezione, in base a: i) esposizione delle esportazioni; ii) livello di surplus bilaterale; iii) strategicità dei prodotti secondo la logica USA di sicurezza economica. Anche in base a questi criteri, rispetto al complesso dei paesi membri, l’export italiano è maggiormente diversificato. Inoltre, i prodotti strategici americani sono più rilevanti sia in termini di varietà che di valore per la media dei paesi europei.
- I primi settori per tutti e tre i criteri (esposizione, surplus e strategicità), sia per l’Italia che per l’Europa, sono quelli della chimica e del farmaceutico. I solidi legami produttivi tra le due sponde dell’Atlantico potrebbero essere un deterrente alla rincorsa tariffaria: oltre il 70% dello stock di capitali investiti dalle imprese farmaceutiche UE nei paesi extra-Ue è diretto negli USA; la quota è la stessa per le multinazionali farmaceutiche tedesche mentre quelle italiane sfiorano il 90%.
- Altri prodotti italiani per cui è rilevante il mercato americano, secondo i criteri di esposizione e surplus, comprendono anche mezzi di trasporto, macchinari e alimentari e bevande: settori merceologici con alta propensione all’export, per i quali la domanda statunitense si è rafforzata negli ultimi anni, quindi altrettanto potenzialmente uno strumento di negoziazione per l’amministrazione USA.
In allegato la nota integrale.
Allegati scaricabili
Nota integrale (PDF - 1.16 MB)
